
Credits immagine: cnbc.com
Definire “filantropo” – come spesso fanno i media – l’uomo più danaroso al mondo è probabilmente un complimento eccessivo. Nondimeno ci sono un paio di oggettive virtù nella Fondazione istituita e alimentata da Bill Gates: l’enormità dei danari erogati in attività sociali (su cui da qualche anno lavora a tempo pieno, avendo abbandonato le sue cariche societarie), nonché il fatto che difficilmente le sue iniziative e prese di posizione siano sospettabili di portare chissà quali “interessi occulti”, in quanto il ricchissimo signore dell’internet economy non ne ha più certo bisogno.
E’ quindi interessante che la Fondazione stessa, storicamente orientata alla lotta alla povertà, abbia ora deciso di puntare la sua attenzione soprattutto sui temi sanitari, lanciando in questi giorni una serie di rapporti e campagne che coinvolgono non solo le aree più povere, ma l’intera popolazione. Con messaggi, nell’insieme, tutt’altro che “allarmistici”.
Viceversa, si sottolinea il ruolo salvifico dei moderni sistemi sanitari, in tutto il mondo, inclusi i più fragili, e si avverte semmai che sono conquiste da consolidare con l’impegno della ricerca scientifica e dell’attività medica. Guai cioè a darle per scontate per l'avvenire, perché non lo sono, e se anzi si torna indietro si rischia di rialimentare l’apparizione di patologie, nuove e anche vecchie
“Abbiamo fatto molta strada nell’impegno su diverse malattie endemiche, dalla malaria alla tubercolosi”, spiega lo stesso Gates al Corriere della Sera - ma il progresso non è inevitabile. Sul fronte dell’Aids, ad esempio, da qui al 2030 avremo ben 5 milioni di morti in più se si materializzerà un taglio dell’assistenza del 10 per cento”. E non è solo un’ipotesi: “La riduzione di fondi che si sta delineando in varie realtà”.
Discorso analogo sui vaccini, che hanno salvato in questi anni milioni di vite alzando significativamente la speranza di vita ovunque: “Una fortuna che è anche un handicap: abbiamo avuto talmente tanto successo con le vaccinazioni che la gente nei Paesi avanzati non vede più da decenni morti per malattie di questo tipo”. Fino a far percepire quei risultati, appunto, come scontati. “Sta diventando un nodo dolente in molti Paesi avanzati, dove in una parte limitata ma significativa della popolazione si registra una crescente diffidenza nei confronti delle vaccinazioni e un’aperta ostilità per la profilassi obbligatoria dei bimbi in età scolastica”, lamenta Gates, e lo lamentano i medici, perfino i più critici e sospettosi verso il mondo della ricerca farmacologica.

180 piazze, medici, altri operatori sanitari e volontari sono lì, a disposizione dei cittadini, per elargire informazioni e raccogliere concrete disponibilità, con la coda del coinvolgimento del campionato di serie A (la quinta giornata, l’infrasettimanale del 19-20 settembre). Si chiama “Match It Now”, è la “settimana della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche”, tema su cui molti connazionali sono virtuosi, eppure non basta. Era solo una “giornata”, e lo è ancora a livello mondiale, ora in Italia si è deciso di alzare l’asticella.
A livello globale sono quasi 29 milioni le persone iscritte nel registro dei donatori di midollo, e l’Italia è, assieme alla Francia, il paese più “generoso,” con circa 1700 donazioni all’anno, del resto in maggioranza dai familiari dei malati. Le patologie coinvolte sono principalmente le leucemie acute, ma anche i linfomi, le mielodisplasie (16%), altre neoplasie ematologiche (8%) e patologie non neoplatiche (9%).
In effetti la vicinanza del donatore rispetto al malato è un aspetto clinicamente rilevante. “E' più facile che un individuo che abiti in Sardegna trovi compatibilità con un donatore sardo. Serve un registro ben differenziato che offra scelta nelle diverse Regioni”, spiega il genetista Licinio Contu, presidente della Federazione Italiana Associazioni Donatori Cellule Staminali. La ragione è che “le persone possono ricevere cellule emopoietiche solo da persone compatibili geneticamente, cosa che raramente avviene”, chiosa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo.
Ed è anche per questo che a volte si elude il problema, pensando che una donazione possa non essere realmente utile. E' un ragionamento sbagliato, perché per approdare alle compatibilità i grandi numeri sono necessari, mentre le donazioni destinate agli sconosciuti crollano sotto la modesta cifra delle 200 l'anno. Insomma, siamo nell’insieme generosi, ma perlopiù quando c’è un’emergenza che ci coinvolga.
C’è un’altra barriera che sotto sotto incombe, ossia la paura che ci possa “far male”. Non è così, soprattutto con le nuove tecnologie. Per donare cellule staminali emopoietiche bastano, nella maggioranza dei casi, prelievi analoghi a quelli che si fanno quando si dona il sangue. La donazione può anzi fare assai bene, anche al donatori. “Con le donazioni si attivano controlli e valutazioni che altrimenti non si farebbero”, ricorda il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi.

Alcuni titoli giornalistici (anche di testate assai serie) sono fuorvianti, lanciando l’ipotesi controcorrente che “i grassi fanno bene”. La realtà, emersa da uno studio americano pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, è un po’ diversa, e meno “confortante”, soprattutto per noi mediterranei. Il tema è la cosiddetta, e piuttosto controversa, “dieta chetogenica”, un percorso alimentare che si caratterizza per l’abbondanza di proteine, piuttosto che di grassi, e soprattutto per il sacrificio dei carboidrati.
Il presupposto è che il livello basso di questi ultimi riduce l’impiego corporale di glucosio, il che permetterebbe di produrre composti chiamati appunto “chetoni” che alimenterebbero l’energia necessaria a bruciare grassi. Confrontando tale dieta con altri regimi alimentari è infatti emerso che la prima avrebbe un impatto positivo sia sulla longevità, sia sulla memoria, sia sulle funzioni motorie (forza e coordinamento), e perfino sui marcatori di rischio tumorale. In sintesi, essa sarebbe capace di rallentare in modo rilevante gli effetti dell’invecchiamento.
Gli stessi ricercatori si son detti “sorpresi e impressionati” dalla differenza riscontrata: un aumento del 13% della vita media dei topi coinvolti nello studio, che hanno seguito una dieta ad alto contenuto di grassi e meno carboidrati, che nell’uomo sarebbe pari a 7/10 anni di vita in più”.
Quell’equazione è peraltro solo virtuale. Sebbene gli studiosi ricordino che alcune caratteristiche metaboliche di fondo sono analoghe tra roditori e umani, l’equivalenza non esiste, tant’è che per qualsiasi conclusione definitiva in ambito medico-scientifico serve il passaggio a una sperimentazione sulle persone. Saranno pertanto necessari ulteriori riscontri, a iniziare dalla ricerca di base.
Nel frattempo, rimane inoltre essenziale evitare il “fai da te”, privo di consulti di specialisti, soprattutto dinanzi alla tentazione di scelte alimentari drastiche. Nondimeno l’indicazione sembra piuttosto chiara, a conferma quantomeno del fatto che il nostro amore per i carboidrati vada soddisfatto con cautela.

Una storia disperata, con un lieto fine che si avvera proprio nel nostro paese e che spalanca una strada finora ritenuta inesplorabile in ambito pediatrico. I protagonisti sono Milana, una bimba ucraina di 2 anni, e l’Irccs Ismett di Palermo. La piccola, sin dalla nascita, soffriva di un’atresia delle vie biliari, che l’ha indotta a un’insufficienza terminale epatica, con l’aggravante di aver contratto l’epatite C, sembra al seguito di una trasfusione di sangue infetto praticatale nel suo Paese d’origine.
L’associazione di una doppia patologia, dunque, rara e grave, e per giunta ritenuta una condizione ostativa sia al trapianto del fegato che, soprattutto, a un trattamento farmacologico anti-virale. Nelle parole del professor Jean de Ville de Goyet, che l’ha poi curata, “quando si è costretti a procedere con il trapianto del bambino in età precoce, la progressione della malattia diventa molto veloce ed il rischio che l’organo trapiantato si ammali nuovamente rendendo il trapianto vano è molto elevato”.
Ed è anche per questo che i familiari si sono trovati ad affrontare diversi no, anche da altri Paesi. In Polonia, ad esempio, racconta la madre Olga, “mi hanno detto che la cura per l’epatite C non era prevista per bambini così piccoli”.
Si è allora giunti alla disponibilità offerta dall’Istituto siciliano, anche per il tramite di una macchina internazionale di sensibilizzazione e solidarietà, per finanziarle il viaggio e per la donazione di organi ed emocomponenti. La scorsa primavera è stato eseguito l’intervento, con trapianto di fegato (donato dalla mamma stessa), seguito da un protocollo sperimentale incardinato su medicinali ad azione anti-virale. L’esito è stato eccellente, con un fegato perfettamente funzionante, senza traccia dell’epatite. “Ha ripreso tutto, dorme tutta la notte, gioca con suo fratello. E’ ritornata ad essere una normale bambina di due anni”, il racconto emozionato della donna.
L’eccezionale novità sta nel fatto che mai un paziente così piccolo era stato trattato con questi farmaci. Ed è un risultato che può estendersi anche al di fuori dei casi di trapianto, quando si preferisce evitare gli anti-virali per il motivo opposto, ossia per il fatto che la progressione di tale patologia nei bambini è solitamente lenta, sicché si preferisce attendere la guarigione prima di somministrarli. A detta dei medici palermitani, si è quindi aperto uno spiraglio inedito, che per molti bambini può essere risolutivo.

Da chiarire subito, a detta degli stessi studiosi americani che hanno scoperto potenziali benefici antitumorali dallo studio di Zika, non si tratta affatto di una smentita circa gli “effetti neurologici devastanti” del virus. Lo scorso novembre l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva declassato l’allarme, lanciato nove mesi prima, quale “emergenza sanitaria globale”, ma ne ha confermato le insidie e l’esigenza di strategie di lungo periodo per una patologia che ha colpito, tra gli altri, almeno un milione e mezzo di brasiliani, con la documentata conseguenza, in particolare, di circa duemila casi di microcefalia, trasmessa dalle gestanti per via fetale.
Nel medesimo orizzonte di lungo periodo balza però una novità promettente, già testata in vitro e su animali. E’ stata annunciata nei giorni scorsi sul Journal of Experimental Medicine, da una ricerca condotta da universitari di Washington e San Diego. Avrebbero documentato che il virus stesso avrebbe la capacità, oltre che di uccidere le cellule progenitrici dei neuroni (ingenerando le anomalie nei feti), anche di eliminare le cellule staminali impazzite. Addirittura, riuscirebbe a debellare quelle che resistono a chemioterapie e radioterapie, legate al “glioblastoma”, ossia alla forma più diffusa (e tra le più letali) di cancro al cervello. L’azione sarebbe per giunta selettiva, bersagliando cioè specificamente le cellule malate e risparmiando quelle sane.
Da notare inoltre che il ceppo utilizzato nella sperimentazione su roditori malati era poco aggressivo, ossia una forma di Zika facilmente contenibile, nei suoi effetti pericolosi, dal sistema immunitario dell’organismo. Al contempo, tuttavia, l’esito è stato rilevante ma non risolutivo, risultando perlopiù efficace nel rallentare la progressione tumorale, non a eliminarla del tutto.
L’intuizione dei ricercatori statunitensi circa i potenziali benefici del “principio attivo” del virus ha dunque trovato riscontro positivo dai test preliminari, ma serviranno perfezionamenti e altre sperimentazioni, anche perché non è detto che il passaggio all’uomo rechi i medesimi effetti. Nondimeno la novità c’è, e apre una strada del tutto nuova nella strategia antitumorale. L’impatto per i pazienti non è dietro l’angolo ma neppure troppo lontano, a parere degli scienziati. “Crediamo che l’utilizzo di Zika in combinazione con le attuali terapie arriverà a sradicare l’intero tumore”, dicono.

Quando incoraggiate I bambini a fare qualche attività fisica non state dando loro solo l’opportunità di un’adeguata e corretta crescita fisica. Il consiglio si rivelerà prezioso anche per le ricadute in età avanzata, con riferimento perfino alle capacità cognitive. Insomma, il “mens sana in corpore sano” prescritto dai latini (che per la verità davano alla frase un significato leggermente diverso) è più che mai valido, e lo è perfino nel lunghissimo termine.
La conferma arriva dalla Deakin University di Melbourne, con uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Ageing Neuroscience, che ha riesaminato la letteratura scientifica in materia. Emerge, e non sorprende, che l’età tra i 40 e i 60 anni è decisiva per costruire le difese contro la demenza. Gli ultra-settantenni che hanno svolto negli anni precedenti almeno un paio d’ore di attività fisica settimanale (anche moderata) hanno rischi quasi dimezzati di sviluppare l’Alzheimer.
Il dato più sorprendente è però un altro, ossia che l’attività fisica nell’adolescenza risulta statisticamente il più forte fattore protettivo contro il deficit cognitivo a 71 anni. La ragione è nel lungo respiro temporale dei cambiamenti cerebrali, che possono tra l’altro manifestare segni di degradazione già vent’anni prima che compaiano seri problemi di memoria.
Il nesso viene spiegato con riferimento all’aumento, alimentato dall’esercizio fisico, dell'ormone della crescita chiamato IGF (insulin-like growth factor) che ha una forte influenza sulla memoria. “Si riteneva che fossimo nati con tutte le cellule cerebrali che avremo avuto a disposizione nel corso della nostra esistenza, ora sappiamo invece che le cellule cerebrali si possono rigenerare nel corso del tempo e che l'esercizio può promuovere una nuova crescita", spiegano gli studiosi australiani.
Si tratta di indicazioni intriganti, che sottolineano le connessioni, anche in un quadro temporale esteso, tra salute fisica e psichica. “Tradizionalmente pensiamo che l’attività fisica porti a benefici cerebrali indiretti, quali il calo di rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari, tumori, ma all’evidenza emerge un ruolo più diretto, strutturale e funzionale”, aggiungono da Melbourne. In particolare, spiegano, “l’esercizio fisico promuove sia la neuroplasticità - ossia la capacità del cervello di adattarsi continuamente nell’arco della vita – che la neurogenesi – ossia la nascita di nuovi neuroni”. Il mantenimento di tali qualità è protetto dall’attività motoria in età avanzata, ma la loro genesi, a quanto pare, viene avviata in giovanissima età.

Le cifre sono impressionanti, e per giunta in crescita. A livello globale le ha rivelate nei giorni scorsi un’indagine dell’Università di Washington pubblicata sulla rivista The Lancet Respiratory Medicine. I malati di sindrome polmonare cronico-ostruttiva (BPCO) sono un’enormità, quasi 175 milioni (e si tratta solo di casi accertati, ci sono stime che raddoppiano tale cifra), e ne muoiono 3,2 l’anno (proiezione su dati 2015), con un aumento costante negli ultimi trent’anni. Nel dettaglio, i decessi erano stati 400mila in meno nel 1900, e lo scarto è ancor più esteso sulle persone ammalate, incrementate del 44,2% in tale lasso.
La differenza tra i due scarti rivela comunque qualche timido segnale positivo. Se ci si ammala di più e si muore di meno vuol dire che qualche passo rilevante è stato fatto a livello di terapie. Quella differenza è ancora più palese per l’asma, aumentato del 12,6%, mentre i decessi si sono ridotti del 26,2%, scendendo sotto la soglia dei 400mila morti annui.
In secondo luogo, anche a detta degli studiosi americani, tali aumenti non sono dovuti a un peggioramento della salute mondiale della popolazione, semmai al suo invecchiamento. Altro dato di relativo sollievo, il problema è esteso anche in Italia, ma un po’ meno rispetto agli altri Paesi avanzati. Sulla BPCO si rilevano 1.765 casi su 100mila abitanti, mentre negli Stati Uniti sono a quasi il doppio. Per quel che riguarda l’asma, i casi sono 3.756 su 100mila, nel Regno Unito quasi il quadruplo.
A incidere su questo andamento sono gli aspetti climatici (legati alla qualità dell’aria, per ragioni climatiche e per diversi livelli di inquinamento), ma anche una presa di coscienza e relativa riduzione (pur solo graduale, con qualche periodico segnale di controtendenza) di alcune cattive abitudini personali, a iniziare dalla più deleteria per il respiro, la sigaretta.
Fondamentali, in tutto questo, anche i progressi scientifici. A Parma, lo scorso maggio, gli esperti mondiali sono convenuti nel “Respiration Day”. Tra le tante novità della ricerca in materia figura anche quella proposta dall’ospitante Fondazione Chiesi: un unico inalatore per a tripla azione, contenente un antinfiammatorio corticosteroide per via inalatoria, un broncodilatatore agonista a lunga durata e un broncodilatatore antagonista del recettore muscarinico. Un dispositivo che semplifica il trattamento con l’obiettivo di aumentare i livelli dell’aderenza terapeutica
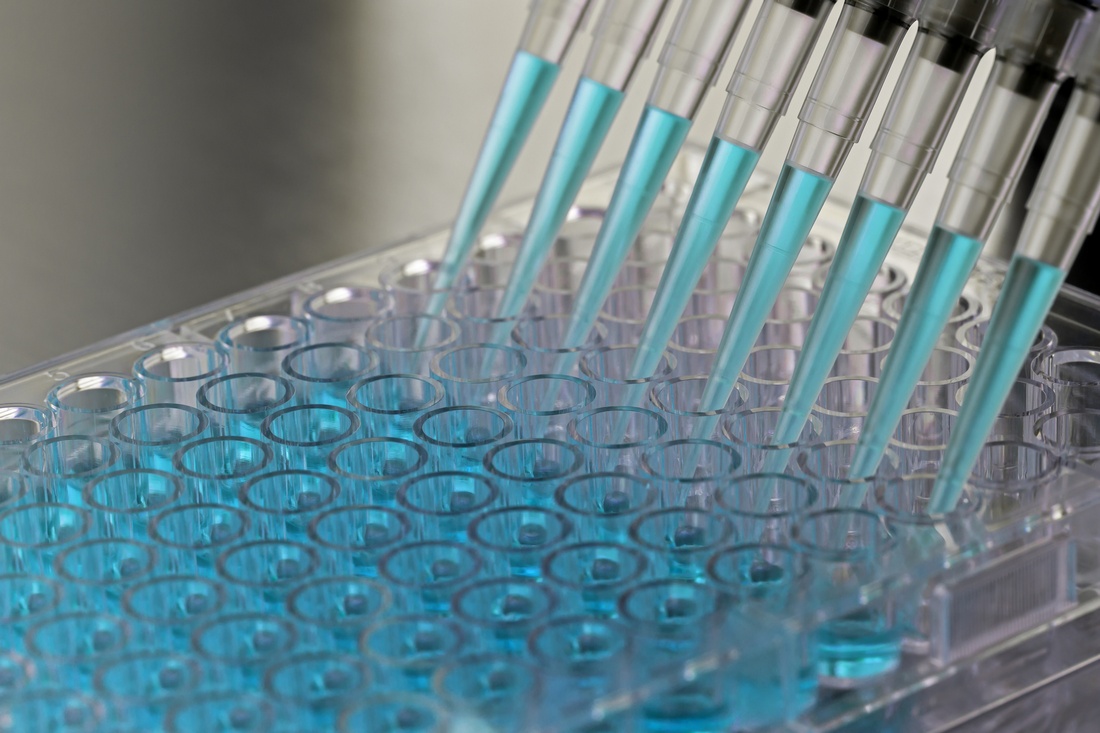
Per sconfiggere l’avversario bisogna conoscerlo, e soprattutto capire perché le difese endogene a volte non funzionino. E’ su questa direttrice che i ricercatori dell’IRCCS dell’Ospedale San Raffaele, in collaborazione con altri istituti lombardi, hanno messo a fuoco il comportamento della proteina p53, nota come il “guardiano del genoma”, nelle sue azioni difensive e nei suoi inceppamenti. Comprenderli significa capire la genesi di molti meccanismi tumorali, e quindi le possibilità di cura.
L’osservazione diretta è stata possibile grazie a una tecnica di microspia innovativa, elaborata nel medesimo centro universitario-ospedaliero. L’aspetto di base è che tale “guardiano”, dinanzi a un danno cellulare, si trova di fronte a due opzioni difensive: avviare un processo di correzione degli errori del DNA o viceversa innescare l’autodistruzione della cellula stessa.
Il problema è che la sola presenza abbondante di tale proteina non è sufficiente a garantire quelle difese, tant’è che il 70% dei tumori è associato a una mutazione genetica che la colpisce e ne danneggia la struttura e potenzialità. Ma il nodo è anche un altro, ossia che il restante 30% si sviluppa anche in assenza di tale mutazione della p53. E’ ad esempio il caso del “neuroblastoma”, un cancro al cervello che colpisce soprattutto i bambini.
C’è dunque un problema di “comportamento” da parte del guardiano. A volte esso è ben presente, senza mutazioni, ma non funziona. Ebbene, all’evidenza dell’osservazione è emerso che la proteina ha bisogno di un aiuto esterno, per preservare la sua funzione anti-tumorale. Nelle parole dell’ideatore dell’apparecchiatura, il fisico Davide Mazza, “solo se attivata, p53 è in grado di associarsi al DNA abbastanza a lungo da avviare i processi per cui è programmata e grazie ai quali i tumori hanno vita tanto difficile”.
In altre parole, la p53 non si attiva da sola, ha bisogno dell’aiuto all’attivazione da parte di altre proteine. Il nostro corpo è un sistema complesso, le cui “cause prime” presentano dinamiche interrelate il cui protagonista non è uno solo, ma tanti. E’ un passo essenziale, dunque, per la comprensione dei meccanismi tumorali e dei bersagli più appropriati per la ricerca terapeutica. E forse anche per la comprensione del nostro sistema cellulare nel suo insieme.
http://www.hsr.it/press-releases/svelato-il-comportamento-del-guardiano-del-genoma/

Il messaggio è da passare con massima attenzione, perché si tratta del campo minato di uno dei comportamenti più deleteri nella storia dell’umanità, ossia il consumo, e soprattutto l’abuso, di alcol. Nondimeno, è interessante, e per certi versi sorprendente, l’esito annunciato da due ricerche europee in materia, che mettono in evidenza alcuni effetti viceversa benefici, naturalmente sempre con il condizionale delle piccole quantità.
La prima, realizzata dall’Università austriaca di Graz e pubblicata sulla rivista “Consciousness and Cognition”, rileva virtù sul piano cognitivo. L’esperimento è stato condotto su due gruppi, in uno si beveva una pinta di birra, nell’altro la si consumava analcolica, e dopo la consumazione i partecipanti venivano sottoposti a una serie di test intellettivi. Anzitutto, è risultato un “pareggio” tra i due gruppi sul piano della generale “capacità di pensiero”. Sul resto, gli “astemi” hanno vinto su un solo aspetto, la “capacità di controllo esecutivo” sul proprio operato.
Ma su altre variabili, è stata la “pinta” a trionfare. In particolare, una (lieve) alterazione sembra avere il potenziale di “sprigionare la creatività”. Viene in mente la buffa risposta dello scrittore Stephen King a chi gli chiedeva se bevesse: “Certo, l’ho già detto che sono uno scrittore”. Non si tratterebbe comunque solo di “fantasia artistica”, ma anche di “resilienza”, ossia di capacità di risolvere i problemi sfuggendo alle barriere razionali e trovando la via d’uscita altrove.
Il vero colpo di scena arriva però dalla Danimarca, dove gli studiosi hanno affrontato il caso del diabete di tipo 2, per il quale su cui l’alcol è generalmente (e giustamente, se assunto in grande quantità) ritenuto un serio fattore di rischio. L’Università di Copenhagen ha quindi riesaminato i dati sui consumi di oltre 70mila persone, svelando infine un colpo di scena. Se cioè l’alto consumo alcolico ha confermato l’aumento di esposizione al diabete, le “piccole quantità” sono risultate non solo innocue, ma addirittura utili alla prevenzione.
L’indagine ha preso in considerazione diverse tipologie di bevande. Tanto per fare qualche esempio, è emerso che gli uomini che bevono un paio di bicchieri di vino al giorno hanno un rischio addirittura dimezzato di contrarre il diabete. Anche una birra farebbe bene, sebbene con una riduzione di rischio inferiore, pari a circa il 21%. Insomma un paio di bicchierini, negli ambiti qui citati, sono addirittura amici della salute. La sfida è semmai quella di fermarsi lì, perché andare “oltre” resta deleterio.

Può sembrare solo un tema frivolo per animare la dialettica tra gli ombrelloni. Invece il quesito è serio e interroga gli scienziati, alla ricerca di una migliore comprensione della nostra struttura cerebrale, anche nelle dimensioni “di genere”, al fine ultimo di migliorare gli aspetti di prevenzione e di terapia dei disturbi neuro-degenerativi stessi.
La sussistenza di differenze tra i sessi nei meccanismi cognitivi è un fatto oramai consolidato nella ricerca medica, oltre che nell'ambito psico-antropologico, che però manca ancora di una “mappatura” dettagliata delle attività tra le varie aree del cervello. Ed è proprio quel che hanno ora tentato gli scienziati di un istituto californiano di Newport Beach, con una robusta ricerca pubblicata sul Journal of Alzheimer's Disease.
Sono state fatte oltre 46mila scansioni cerebrali tramite la risonanza detta Spect (tomografia a emissione di fotone singolo), su ben 128 regioni del cervello, ripetendole mentre i soggetti, di ambedue i sessi, erano impegnati in test cognitivi oppure a riposo, e valutando la diversa intensità degli flussi di sangue.
Da tutto questo è emersa una differenza rilevante tra i due sessi: le donne sono risultate particolarmente attive sia nella corteccia prefrontale – associata nel controllo degli impulsi e della messa a fuoco - che nel sistema limbico – che regola le “emozioni”. L’attività cerebrale maschile ha però comunque segnato una “rivincita” nelle aree legate al coordinamento. Segnali che peraltro tendono a confermare che molti pensano intuitivamente. Emergerebbe dunque una superiorità femminile nel riconoscimento delle emozioni, nell’intuito, nella capacità empatica verso l’altro, mentre gli uomini si difenderebbero nell’ambito dell’analisi razionale.
L’obiettivo della ricerca era comunque terapeutico, mirando anzitutto a identificare le ragioni dell’esposizione a diverse patologie. Da quest’ottica, risulta che il genere maschile “vinca” in fatto di problemi “comportamentali” (incluso l’ambito criminale), ma le donne sono specularmente più esposte ad ansia, depressione, insonnia, disturbi alimentari e perfino patologie gravi come l’Alzheimer. Chissà se dietro a tutte queste verità fisiologiche non agiscano variabili culturali, antiche, di ruolo sociale. Qualunque sia la ragione prima, o ultima, la differenza c’è, e la sua comprensione è cruciale in vista di una “medicina di precisione”, nella quale il genere dei pazienti appare un fattore essenziale.

“Mangiate bene”, si consiglia spesso agli studenti o ad altri alle prese con esami e particolari sforzi cognitivi. Che la qualità alimentare sia una variabile rilevante per le capacità cognitive è un dato assodato, ma continua ad arricchirsi di ulteriori specifiche. L’Ultima, pubblicata dalla rivista Appetite, arriva dall’Università (australiana) di Newcastle, e introduce anche un curioso elemento di mistero.
In sostanza, da una sperimentazione su 4200 alunni delle scuole secondarie (che comunque “spuntava” altre variabili, quali il genere e il background socio-economico), è emersa un’incidenza rilevante di alcuni fattori alimentari sul rendimento scolastico.
Anzitutto, il consumo regolare di verdure a cena è risultato al vertice delle variabili. Poi, è emerso che almeno due frutti al giorno sono cruciali per conseguire voti più alti, soprattutto nelle materie linguistiche. Al vertice opposto, l’assunzione eccessiva di zuccheri e bevande industriali è risultata associata a voti più bassi, con particolare riferimento alla lettura.
Queste sono insomma le massime priorità, positive e negative. “Finora i dati scientifici in materia coinvolgevano perlopiù l’importanza di una buona colazione”, spiegano gli studiosi di Sidney, rivendicando la scoperta di correlazioni dirette degli alimenti citati, nel bene e nel male, con gli effetti cognitivi, e in particolare in tema di rendimento scolastico.
Permane un aspetto misterioso da esplorare, che ha destato sorpresa tra gli stessi ricercatori australiani. Le prescrizioni suddette hanno un effetto evidente in quasi tutte le materie di studio, ma ce n’è una che fa eccezione: la matematica. Su questo la qualità alimentare sarebbe irrilevante. E qui possono scatenarsi le interpretazioni. All’evidenza, sembra che una buona alimentazione possa irrobustire le capacità cognitivo-creative, e una cattiva alimentazione possa viceversa danneggiarle, ma la “struttura logica” del nostro cervello può “campare” lo stesso, nutrita anzitutto da solide variabili non-alimentari.

Nel rituale dei suggerimenti sanitari in tempi di torrida calura le indicazioni più ricorrenti sono quelle rivolte alla popolazione anziana. Non fa eccezione quest’estate, ritenuta “tra le più afose della storia”. Solo che ai sacrosanti consigli ai singoli va aggiunta una priorità superiore, ossia l’importanza di non lasciare gli anziani da soli. C’è chi si muove su questo, ed è il caso, tra gli altri, della Comunità di Sant’Egidio nell’area romana.
Il tema è vastissimo, in quanto le persone in età avanzata che vivono da sole in Italia sono quasi quattro milioni. E sono (assieme ai bambini) le più esposte ai problemi di disidratazione e di colpi di calore, che vanno ad aggiungersi alle pregresse debolezze e, talora, patologie. Anche Federanziani ha proposto un “decalogo” che ricorda i comportamenti corretti per difendersi dalle alte temperature.
Paletti forse scontati, ma non sempre osservati, sicché è bene ricapitolarli. Evitare le uscite nelle ore più calde, specie nelle zone molto trafficate. Bere tanto (acqua anzitutto, e comunque non alcolici), almeno un litro e mezzo di liquidi per reintegrare i sali minerali. Alleggerire i pasti, bene i carboidrati, la frutta fresca, la verdura di stagione, male i fritti e gli altri preparati grassi. Poi, naturalmente, aprire le finestre ma non nelle ore più calde della giornata, usare gli occhiali da sole (e le creme protettive della pelle, se si sta in spiaggia), e abiti leggeri con preferenza per le fibre naturali. Ancora, non trascurare le cure mediche o farmacologiche, come si tende spesso a fare d’estate, se non su consiglio medico.
Poi c’è il consiglio di cercare riparo vacanziero in luoghi freschi, ma il fatto è che tanti non possono permetterselo. E qui entra il nodo della necessaria solidarietà. “Più che il caldo è spesso l’isolamento sociale a fare vittime”, nota la Comunità di Sant’Egidio, con un appello a tutti a prestare attenzione agli anziani, parenti, ma anche vicini di casa, nonché persone incontrate in strada che vediamo in difficoltà.
A tal fine si inserisce il programma “Viva gli Anziani”, allestito dall’organizzazione già dal 2004 nella capitale, per una presa in carico che prevede un sistema articolato di sostegno, tra assistenza domiciliare, attivazione di reti sociali di supporto, monitoraggio sulla salute. Muovendo da una priorità: quella appunto di non lasciare nessuno da solo, che è il primo degli accorgimenti sanitari.

Nei giorni scorsi si sono moltiplicati i lanci d’agenzie stampa e gli articoli giornalistici sull’ultimo rapporto del Censis sulla salute degli italiani e i relativi costi, destando qualche perplessità di vari tipo tra gli addetti ai lavori (della sanità e dell’informazione) nonché tra cittadini e pazienti. Per questi ultimi, è stata una presa d’atto, se non la conferma, di una situazione di seria difficoltà delle persone a curarsi, specie in tempi di difficoltà economiche e limiti alla spesa pubblica. Per altri una ripetuta esagerazione.
Il rapporto dice che gli italiani sono stati costretti, nel 2016, a spendere di tasca propria (per gli alti costi e le estenuanti liste d’attesa) la cifra di ben 37,3 miliardi di euro, mentre la spesa pubblica nel settore, in rapporto al Pil, è rimasta assai inferiore agli altri Paesi europei: da noi è al 6,8%, in Germania arriva al 9. L’esito ultimo, in tempi di bassi salari e disoccupazione, è che il numero degli italiani che rinunciano alle cure almeno una volta l’anno per mancanza di denari è salito a 12,2 milioni, ben 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente.
Dati talmente pesanti che lo stesso Ministero della Salute ha ritenuto di dover puntualizzare. Anzitutto notando come si trattasse di “dati vecchi”, già divulgati due mesi fa (e infatti pubblicati anche da noi). E poi contestando la cifra delle persone che rinunciano alle terapie. “E’ solo una proiezione su un’indagine campionaria, ed è in evidente contrasto con due precedenti indagini Istat su vastissima scala”, obietta il dicastero, argomentando che il dato reale corrisponderebbe solo a un terzo di quello indicato dal Censis.
Puntualizzazioni a parte, il problema c’è, fossero anche solo 4 milioni quelli che non possono permettersi di curarsi. E’ un problema esteso, che richiama anche la priorità etica di ricordare la possibilità di ricorso ai farmaci equivalenti, di accertata efficacia e sicurezza terapeutica. E ricade inoltre sulla qualità dell’alimentazione, in un circolo vizioso per la salute.
Una ricerca molisana, dell’Istituto Irccs Neuromed di Pozzilli, ha infatti accertato che “la dieta mediterranea fa bene, ma solo ai benestanti”. A parità di consumo di pesce, frutta, cereali “buoni” che hanno fatto la fama mondiale, oltre che la salute, delle nostre tradizioni, inciderebbe tantissimo la qualità (e quindi il costo) dei prodotti acquistati, sul nostro benessere. E’ un problema drammatico. Che coinvolge la scelta (per cause economiche) dei cibi, freschi o non freschi, ma, si badi, non riguarda invece affatto la scelta tra medicinali di marca o meno. Su questo la differenza di prezzo dipende solo dalla scadenza del brevetto del brand, nient’affatto dalla qualità.

“Signore, fate lo jogging”, dicono i ricercatori britannici. Sembra l’ennesimo e scontato appello alla mobilità fisica per la prevenzione dell’indebolimento osseo, specie tra le donne, ma c’è una specifica ulteriore, che per molte può fare la differenza: basterebbe davvero poco, pochissimo, per evitare guai peggiori.
Lo studio, condotto dall’Università di Exeter, in collaborazione con quella di Leicester, e pubblicato dall’International Journal of Epidemiology, fissa alcuni paletti, alla portata di tutti e rivolti in particolare ai soggetti più a rischio, ossia le donne in menopausa. Gli studiosi hanno esaminato i dati fisiologici di oltre 2.500 soggetti di sesso femminile valutando in particolare la salute delle loro ossa (valutata con scansione a ultrasuoni) e confrontandone i livelli di attività fisica, misurati con monitor da polso.
E' emerso che un solo minuto o due di movimento quotidiano ad alta intensità, ripetuto per cinque giorni alla settimana, è sufficiente a potenziare le ossa, con un margine di miglioramento calcolato al 4%. “Il nesso è evidente”, sottolineano i ricercatori, aggiungendo un solo elemento di cautela: “Non sappiamo ancora se sia meglio effettuare quel breve esercizio una volta al giorno, oppure accumulare il programma settimanale in un giorno solo”.
Basterebbe dunque assai poco per migliorare la salute ossa, sebbene gli stessi scienziati inglesi ammettano che, spingendo oltre la soglia dei due minuti, si possono ottenere risultati ancor più convincenti, salendo dal 4 al 6% nel potenziamento.
E' interessante anche l'enfasi posta sul movimento “intenso”, quale una corsa ben sostenuta, nei limiti delle proprie possibilità, naturalmente. Viene ritenuta più benefica per le ossa perfino al confronto con una più estesa passeggiata. Camminare fa comunque bene, naturalmente, e lo ribadiscono gli stessi ricercatori britannici, ma con un consiglio in più, quello di aggiungere appunto un pur breve scatto: “Come quando d'improvviso ci si mette a correre per prendere l'autobus in partenza”, concludono.

Molti lo chiamano così, alcuni lo ritengono un termine improprio. Il cosiddetto “pre-diabete” rappresenta una condizione ad alto rischio di contrarre il diabete mellito di tipo due, che andrebbe riconosciuta e trattata con serietà, per evitare seri guai successivi. E’ di questi giorni la pubblicazione dei risultati di uno studio in materia realizzato dall’Università australiana di Newcastle, nonché di un “pentalogo” proposto da una rivista divulgativo-scientifica britannica, che convergono su alcuni capisaldi di prevenzione.
Col termine “prediabete” si identifica uno stato largamente (se non del tutto) asintomatico, quindi spesso non riconosciuto dalle persone per lunghi periodi, definito da livelli di glucosio e insulina superiori alla norma, ma non al punto da determinare un diabete conclamato. E’ diagnosticabile alla luce di una alterata glicemia a digiuno e di una ridotta tolleranza al glucosio, variabili che possono e dovrebbero essere trattate tempestivamente.
La sperimentazione australiana, condotta su un centinaio di volontari tramite una dieta con pochi grassi e un aumento dell’esercizio fisico, è giunta alla duplice conclusione di una rilevante perdita di peso e un miglior controllo glicemico. Ma l'aspetto più innovativo consiste nel fatto che i risultati migliori sono stati registrati proprio tra i partecipanti “preglicemici”. Basta una passeggiatina di una mezz’oretta al giorno, all’evidenza anche di altri studi, e il rischio di contrarre il diabete risulterebbe più che dimezzato.
Sulla scia di questo e altri studi, la rivista britannica The Conversation ha dettagliato un percorso alimentare di prevenzione sulla base di cinque paletti fondamentali. In primis, un alto consumo di frutta e verdura, specie a foglie verdi, affiancato da una diminuzione dei consumi animali. Poi c’è il suggerimento di un consumo moderato caffè, magari decaffeinato, per usufruire dei suoi benefici effetti sul metabolismo.
Infine, non ultimo, a fianco dell’imperativo generale di evitare cibi ad alto contenuto glicemico (inclusi i carboidrati lavorati), c’è il “divieto” delle bevande industriali, che risultano attraenti soprattutto d’estate. Una sola bevanda al giorno è associata a un aumento di rischio diabetico del 13%. Consigli da prendere sul serio, per tutti. E per valutare chi è a particolare rischio, basta un semplice esame della glicemia a digiuno: chi sta sopra quota 100 e sotto quella di 125 è defnibile come “pre-diabetico”. Possiamo infischiarcene ma, allo stadio successivo, se non cambiamo qualche comportamento, ce ne pentiremo.

Da tempo c’è un gran parlare di “territorializzazione della Sanità”, per liberare la cura dalle mura ospedaliere – al di fuori naturalmente dei casi più gravi – e avvicinarla ai cittadini. La principale rete associativa nazionale, Cittadinanzattiva, ha allora cercato di fare il punto, in collaborazione con altre associazioni di pazienti, di professionisti sanitari, nonché enti territoriali e sindacati. Tracciando un quadro globalmente modesto, tra palesi lacune e gravi differenze regionali, con l’esito ultimo che sono i cittadini, infine, a pagarsi privatamente una buona parte dell’assistenza, del resto solo quando possono permettersela.
Tra le carenze, c’è la “cronicità” della lentezza e dei ritardi. Più di un cittadino su dieci attende oltre un mese per ricevere farmaci indispensabili, uno su quattro aspetta il medesimo lasso di tempo per un materasso o un cuscino antidecubito giudicati indispensabili, uno su tre per una carrozzina. Un paziente su sette poi incontra criticità nell’attivazione del servizio di infermieristica o fisioterapia, anche dopo la sua formale assegnazione. Quando il servizio è fornito i pazienti si dichiarano largamente soddisfatti per la qualità e la sensibilità degli operatori, salvo il problema, lamentato da quasi la metà dei cittadini, che tali operatori non sono quasi mai gli stessi, ruotano troppo spesso. Questione di burocrazie ancora poco accessibili. E di organizzazione.
I problemi emergono già nella semantica: gli appellativi cambiano anche solo sconfinando da una Regione all’altra. Su base nazionale ci sono le “Aggregazioni Funzionali Territoriali” (Aft), che però localmente si declinano in modalità variabile nelle cosiddette “Unità Complesse di Cure Primarie”. Queste si chiamano “Case della Salute” in Emilia Romagna, si sale oltre la “frontiera” del Veneto diventano “Medicine di Gruppo Integrate”. E nella confusione finisce che in una Regione su tre il previsto coordinamento tra Aft e Unità complesse non è stato neanche attivato.
A proposito di sperequazioni territoriali, emerge poi che i Centri diurni per la salute mentale sono 3 nel Molise, mentre sono 69 in Toscana, quelli per l’Alzheimer sono 4 in Campania e 109 in Veneto. Si dovrebbe allora quantomeno seguire il criterio adottato per gli ospedali: bisogna stabilire “standard qualitativi, strutturali, tecnologici a garanzia di tutti i cittadini in tutte le aree del Paese. Abbiamo bisogno di poter trovare nel territorio un punto di riferimento affidabile e presente sempre”, incalza il Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva Tonino Aceti.
Tra disservizi e differenze regionali finisce che i costi vengano poi scaricati sui cittadini. Costretti a pagare di tasca propria l’assistenza essenziale in un caso su due, e in uno su dieci a spendere oltre mille euro al mese, tra badante, fisioterapista, materiale sanitario e farmaci. Un onere che potrebbe essere alleviato anche attraverso il ricorso ai farmaci generici, come ricorda “IoEquivalgo”, la campagna attivata sempre da Cittadinanzativa per sensibilizzare al loro uso e contenere almeno in parte il fenomeno dell’abbandono delle cure legato al costo elevato dei medicinali.

“Una robusta colazione al giorno leva il sovrappeso di torno”. Qualche blogger americano sintetizza così l’esito di uno studio californiano, in via di pubblicazione sul Journal of Nutrition, presentato in questi giorni a Washington all’International Conference on Nutrition in Medicine. Non è certo una novità il consiglio di un inizio ben nutrito della giornata, per l’energia che il nostro corpo richiede, nonché per la sua capacità di “bruciare” le calorie ingerite di buon ora, ma adesso arriva una specifica ulteriore tramite uno studio di vasta scala: quel pasto è cruciale perfino all’obiettivo di perdere peso.
Gli scienziati della Loma Linda University School of Public Health, in collaborazione con due Istituti di Praga, hanno esaminato nell’arco di sette anni le abitudini alimentari di oltre 50mila ultratrentenni, anche con il tramite di periodici questionari. L’esito più vistoso e meno confutabile riguarda la colazione. Chi la saltava teneva a ingrassare di più, e non di meno. Inoltre, chi faceva della colazione il pasto più succulento della giornata raggiungeva i risultati migliori in termini di Indici di Massa Corporea.
Più discutibile un altro risultato annunciato dai ricercatori, ossia che il numero complessivo di pasti giornalieri sia funzione diretta dei rischi di sovrappeso. Verrebbe cioè contraddetto l’imperativo del “mangiare poco ma spesso”, promuovendo invece un paio di “abbuffate” quotidiane, senza ulteriori apporti di merende o simili. L’aspetto debole qui sta nel fatto che la correlazione potrebbe anche determinarsi dal solo fatto di un quantitativo globalmente superiore di cibo in una quantità maggiore di pasti, e soprattutto non sembra tener sufficiente conto della loro qualità.
A tal proposito, uno studio italiano (finanziato dalla Fondazione Barilla) rilancia i benefici di una buona dieta mediterranea, per perseguire i propri obiettivi “di linea”, oltreché di salute. Nel “decalogo”, si ribadiscono le priorità su cereali integrali, l’olio extravergine di oliva, tanta acqua, frutta e verdura, il consiglio a ridurre la carne e i formaggi, da sostituire con le proteine vegetali, quali i legumi. Bene il pesce, specie quello azzurro, bene anche limitare il sale.
E poi, naturalmente, l’appello a un’adeguata attività fisica, a iniziare dalla semplice camminata o pedalata. Insomma, bisogna muoversi, almeno un po’, tranne in un caso, ossia proprio quando si sta a tavola. “Lentezza”, “convivialità”, le parole d’ordine, celebrate anche dall’Unesco nel riconoscere la dieta mediterranea come “Patrimonio dell’Umanità”. Con una priorità in più, a quanto pare: quella di una buona e solida colazione, senza troppe preoccupazioni sugli eccessi.

Danni fisiologici, rischi tumorali, l’inquinamento causato dalle onde emesse dai dispositivi. Sono diversi gli allarmi e gli studi che, seppur tra qualche parziale obiezione qua e là, forniscono un sacrosanto richiamo alla cautela sull’uso dei telefonini. Dall’Università del Texas (ad Austin) ne arriva uno ulteriore, che si concentra sugli aspetti psicologico-cognitivi, e ne documenta il danno.
Gli studiosi americani hanno coinvolto quasi 800 utilizzatori di smartphone, sottoponendoli a una serie di test, e introducendo alcune variabili in relazione al dispositivo stesso: questo veniva posizionato per alcuni sulla scrivania, per altri nella loro tasca o borsa, per altri ancora in un’altra stanza, in tutti i casi con la raccomandazione di disattivarne i suoni, in modo che non fossero mai di apparente disturbo alla concentrazione sul lavoro richiesto.
Ebbene, al termine dei vari test, è emerso un esito chiaramente migliore tra i partecipanti che tenevano il telefonino nell’altra stanza, a decrescere progressivamente in relazione alla sua accessibilità. “Una tendenza lineare, quanto più lo smartphone è percettibile, tanto più le capacità cognitive diminuiscono”, spiegano gli scienziati americani, notando per giunta come fosse irrilevante la variabile sull’accensione o meno del telefonino.
Insomma, la sola presenza sarebbe sufficiente a “spegnere” almeno parzialmente il cervello. “Non è che il cervello pensi coscientemente allo smartphone, ma il fatto che si sia attiva il cosiddetto brain drain, ossia il processo attraverso il quale ci si richiede di meno, ci si permette di limitare l’uso delle proprie risorse cognitive”, commentano dal Texas.
In altre parole, il nostro cervello tende ad adagiarsi a quel che tende a considerare il proprio sostituto, o quantomeno un prezioso ausilio. Si tratta di esiti che possono essere scontati, ma che rivelano una verità profonda, da consegnarsi non solo alla scienza e all’ambito psicoterapeutico, ma al genere umano, sin dall’età evolutiva. Quell’oggetto che sembra racchiudere il mondo, per le sue possibilità infinite di informazione e di comunicazione, pubblica e privata, in realtà toglie qualcosa a noi stessi. All’evidenza, dimenticare ogni tanto quell’oggetto a casa può non essere un problema, bensì la nostra salvezza.

Tra i tanti misteri che ancora avvolgono le origini di una patologia così grave prende corpo un’ipotesi pressoché nuova e, a quanto pare, assai plausibile. Si tratta dell’intestino, ovvero della sua flora batterica, ed è una pista tracciata proprio uno studio in Italia, sostenuto dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (e relativa Fondazione), con esiti pubblicati sulla rivista internazionale Science Advances.
Gli studiosi dell’Ospedale San Raffaele di Milano hanno esaminato nell’arco di due anni i tessuti intestinali di 19 malati di sclerosi multipla recidivante-remittente (distinguendo poi tra quelli con malattia in fase attiva e i pazienti in fase remissiva), comparandoli coi tessuti di 18 persone sane, osservando sia le cellule del sistema immunitario che le popolazioni batteriche.
E’ emersa in particolare, tra i malati, una quantità aumentata dei linfociti TH17. Questi, ricordano i ricercatori, “sono le prime cellule del sistema immunitario a superare la barriera ematoencefalica e a raggiungere il sistema nervoso centrale, contribuendo al danno del rivestimento mielinico”, tant’è che una molecola da loro prodotta, l’interluchina-17, è ampiamente presente nelle lesioni cerebrali seguite alla malattia. Da qui la conclusione che tali cellule immunitarie possano essere responsabili della stessa sclerosi.
Ma che c’entrano in tutto questo i batteri? Qui sta la documentata novità, in quanto nei pazienti con malattia attiva spuntano al contempo “due vistose anomalie, una quantità ridotta di Prevotella, batterio che riduce il differenziamento dei linfociti in cellule TH17, e l'aumento di due ceppi di Streptococco (oralis e mitis) che solitamente risiedono nella cavità orale e hanno notevoli capacità infiammatorie”.
Morale - anche se serviranno, a detta degli studiosi stessi, ulteriori riscontri e specifiche sui rapporti di causa ed effetto - la flora batterica intestinale ha senz’altro un ruolo nella patogenesi della malattia. “I batteri che vivono nel nostro intestino interagiscono continuamente con il sistema immunitario. L'alterazione del loro equilibrio favorisce uno squilibrio immunologico a livello intestinale ma anche sistemico, con conseguenze importanti nel campo di tutte le malattie immuno-mediate”, spiegano gli scienziati. Tra queste, oltre alla sclerosi, c’è il diabete di tipo 1, a ulteriore sottolineatura del potenziale di questo filone di ricerca rilanciato in Italia, con quel che comporta sul piano degli orizzonti terapeutici.

“Cucinare ingrassa”, si dice spesso, pensando perlopiù all'inevitabile pur cauto assaggino, qua e là, della pietanza in preparazione. Ebbene, da una ricerca scientifica americana, pubblicata sulla rivista Cell Metabolism, arriva non solo una conferma scientifica, ma altresì l'individuazione di una causa ulteriore e sorprendente, ossia l'olfatto. Basterebbe cioè “annusare” il cibo per mettere sotto pressione il nostro peso forma.
In una serie di sperimentazioni sui roditori, è emerso che quelli che annusavano il cibo, o avevano comunque un senso più sviluppato dell'olfatto, tendevano a ingrassare molto più degli altri, a parità di consumi alimentari. La spiegazione data dagli scienziati è che l'olfatto spingerebbe il corpo a conservare le calorie piuttosto che bruciarle, e, a controprova di questo c'è il fatto che le nostre capacità olfattive tendono ad aumentare quando siamo affamati, mentre diminuiscono dopo mangiato.
“Per la prima volta si dimostra che se riusciamo a manipolare gli input olfattivi possiamo realmente alterale le percezioni mentali sulla bilancia energetica, e quindi il modo con cui la regola”, annunciano gli studiosi dell'Università della California. E la dimostrazione si è avuta anche testando una terapia genica che agisce sull'ambito neurologico delle percezioni, “silenziandole”: gli esiti hanno confermando le intuizioni suddette, ma il trattamento utilizzato ha come controindicazione dell'incremento dell'ormone chiamato “noradrenalina”, a livelli che, per gli umani, aumentano i rischi di infarto.
Il concetto comprovato è comunque rivoluzionario e promettente per la ricerca. “I nostri meccanismi sensoriali hanno un ruolo nel metabolismo: l'accumulo di peso non è solo la misura delle calorie ingerite, ma anche della loro percezione”, spiegano gli scienziati. Il che apre a ricadute non solo sul controllo della “linea”, ma anche sul trattamento di seri disordini alimentari.
Insomma l'intero tema del metabolismo sarebbe anche una questione di “testa”. Spesso – notano ancora i ricercatori – i malati di Parkinson, tra gli altri, diventano anoressici, senza che sia mai stato chiaramente trovata la spiegazione scientifica. Motivi di stress, depressioni, se non patologie psichiche, che sovente si associano alla perdita di appetito. In ogni caso, l'ambito emotivo, neurologico, c'entra eccome.