
Riconoscere un problema è il primo passo per poterlo superare. L’importanza, definita “epocale” di una ricerca anglo-americana, risiede proprio in questo: l’esser riusciti a visualizzare per la prima volta, ad altissima risoluzione, i dettagli atomici della cosiddetta “proteina Tau”, largamente ritenuta la molecola celebrale chiave nel processo neuro-generativo legato all’Alzheimer.
Il notevole passo avanti, annunciato anche dalla rivista Nature, è di un gruppo di scienziati del britannico Medical Research Council assieme all’Indiana University School of Medicine. Lo studio ha permesso di individuare con chiarezza i filamenti della proteina, invisibili ai tradizionali microscopi, la cui presenza è considerata un marcatore dell’Alzheimer, alterando la funzionalità “stabilizzante” della molecola. Il risultato è stato ottenuto tramite “crio-micro-spia elettronica”, una tecnica utilizzata di recente per la visualizzazione molecolare a temperature molto basse.
“Si tratta di risultati scientifici importanti e promettenti, i più importanti nell’ultimo quarto di secolo”, sottolineano i ricercatori. E sarebbe un’ottima notizia per una patologia che coinvolge in Italia circa 600mila ultrasessantenni, e che richiede anzitutto una diagnosi tempestiva, su cui si fa in effetti molta ricerca nel nostro Paese, fino a poter predire forme di demenza “con un anticipo di otto anni”, secondo un recente approfondimento dell’Università di Firenze sulla base di dati comportamentali.
Sempre dall’Italia, è emersa di recente, dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, la scoperta di un meccanismo di origine della malattia, scovato nell’area cerebrale della produzione della dopamina, neurotrasmettitore cruciale sulle dinamiche “umorali”, coinvolgendo anzitutto la cosiddetta area tegmentale ventrale, prima ancora dell’ippocampo. In altre parole, i processi di perdita della memoria non nascerebbero dall’area a essa primariamente associata, ma dal malfunzionamento di tali “meccanismi emozionali”.
Sono intuizioni preziose, che dal nostro Paese allargano la metodica e l’orizzonte dello studio della patologia. Dallo studio anglo-americano emerge però ora la possibilità coadiuvante di “vederla”, come prima non era mai stato possibile. Con quel che potrebbe rapidamente conseguire per dettagliare la comprensione del problema, dalla sua genesi ai potenziali terapeutici.

Rischi tumorali, melanomi, carcinomi, seri problemi agli occhi, invecchiamento precoce della pelle. Sono tantissime le controindicazioni di un'eccessiva esposizione al sole, e tuttavia gli italiani, sebbene rivendichino generalmente di essere padroni ed esperti della materia, spesso si proteggono assai male. A rinnovare l'allerta in materia è l'esito di un'apposita indagine divulgata nei giorni scorsi sui nostri comportamenti in spiaggia.
Emerge tra l'altro che oltre la metà degli italiani non prende le giuste cautele perché ha fretta di scurirsi. Il 45% addirittura utilizza creme abbronzanti al posto di quelle protettive, con l'esito che il 66% si procura rilevanti scottature, e un terzo dei bagnanti subisce colpi di calore.
Alcuni degli errori sono suscitati dall'istinto di accelerare appunto l'abbronzatura, ma a incombere è anche una diffusa disinformazione. Un portale internazionale ha fatto ad esempio il punto sui “falsi miti” in materia di creme solari. Tra i più plateali, l'idea che non sempre esse siano necessarie, ad esempio quando il cielo è nuvoloso; poi quella secondo cui la protezione non faccia assorbire la benefica vitamina D, mentre in realtà bastano pochi minuti al processo. Ancora, il falso secondo cui chi ha la pelle più scura non necessiti protezione. Oppure il mito che un'applicazione basti per la giornata, mentre andrebbe applicata ogni due ore o poco più, specie se dopo la prima applicazione si è fatto un bagno.
I concetti sono largamente ripresi nelle avvertenze del ministero della Salute, che ricorda i seri rischi sanitari della sovraesposizione, e aggiunge qualche consiglio concreto. Anzitutto, utilizzare le creme “per integrare, ma non per sostituire, i metodi fisici di protezione dalle radiazioni UV (indumenti, cappello, occhiali, ombra) soprattutto nelle ore centrali e più calde della giornata”.
Confermata inoltre la “bocciatura” degli autoabbronzanti (“hanno solo un effetto cosmetico e non "preparano" la pelle al sole”) e delle lampade solari (“un ulteriore rischio per l'insorgenza dei tumori della pelle e sicuramente accelerano l'invecchiamento cutaneo provocando un aumento delle rughe e delle macchie”), sfatando in proposito un altro mito perorato da alcuni: “Anch'esse – si legge - non hanno alcun effetto protettivo rispetto ai raggi solari”. Sapevamo tutti già tutto? All’evidenza, purtroppo, no.

“Quando la moglie va in vacanza” ci rievoca la magnifica e spiritosa Marilyn Monroe, o anche il grande regista Billy Wilder, pur tra battute e qualche lacrima di nostalgia. Ad andare in vacanza, tuttora, è però anche il medico, il che solleva a volte qualche ansia, soprattutto per le sacrosante esigenze degli anziani. E’ allora tempo di ricordarci qualche appiglio possibile in assenza dell’operatore (e soprattutto in presenza di temperature insopportabili), nell’ambito dell’assistenza sanitaria ma anche dei comportamenti privati.
Anzitutto meritano di essere rispolverate un po’ di informazioni di pubblica utilità, visto che talvolta è la stessa ignoranza sui propri diritti a innescare angosce, anche al di fuori dell’ambito sanitario. Per esempio, non tutti sanno che se non c’è il medico di famiglia si può consultare il sostituto, da lui nominato, e tenuto alla reperibilità, quantomeno negli orari e giorni feriali (ossia dal lunedì al venerdì). In sua ulteriore assenza, le Regioni devono comunque allestire una rete di ambulatori disponibili nell’ambito della propria Asl.
Al di fuori di tali orari, inoltre (e al di là dei servizi di assistenza e volontariato allestiti in molti territori, raggiungibili tramite il numero telefonico ministeriale 1500), dovrebbe essere sempre attivo un servizio di Guardia Medica, nonché quello per le emergenze sanitarie, contattabile al 118.
Al di là di tutto questo, peraltro, vale sempre, soprattutto nei contesti e periodi di assistenza ridotta, la regola che si può aver cura di sé prima dell’insorgenza del problema, e questo riguarda anzitutto le fasce deboli per eccellenza, ossia gli anziani stessi. Un ulteriore riscontro sull’importanza della prevenzione è arrivato nei giorni scorsi da uno studio dell’Università di Singapore che documenta come il rischio di deficit cognitivi aumenti di ben 8 volte tra gli anziani fisicamente fragili, e la compresenza delle due debolezze incrementi di 20 volte l’esposizione alla disabilità, al ricovero o addirittura alla morte.
Tali esiti possono suonare scontati, ma il problema è che spesso non ci si muove di conseguenza. E bisognerebbe farlo, come hanno sperimentato gli stessi studiosi. Una combinazione di una buona attività fisica, di un’adeguata alimentazione e di uno stimolo cerebrale ha il documentato potenziale di ridurre al contempo la fragilità fisica e i sintomi cognitivo-depressivi. In definitiva, l’assistenza sanitaria c’è, o almeno dovrebbe esserci, anche quando il medico è in vacanza, ma la prima cura (e spesso la migliore) rimane quella che ciascuno, anche in età avanzata, può mettere preventivamente in atto, pur nei limiti delle proprie possibilità e inclinazioni.

Viaggiare è per molti il massimo dei piaceri, al punto che, secondo le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2015 i turisti sono stati complessivamente circa 1,2 miliardi, con tendenze all'ulteriore aumento. A volte però ci si rovina la vacanza ammalandosi, ed è un rischio che si alimenta in alcuni contesti, dove permangono patologie e virus insidiosi, altrove debellati. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie statunitensi hanno quindi aggiornato il loro apposito “Yellow Book”, che tiene conto delle segnalazioni internazionali e include nelle sue “avvertenze” anche il nostro Paese.
In cima alle preoccupazioni rimangono l'Asia e l'Africa Sub-sahariana, dove si registrano globalmente il 60% delle malattie di viaggio, quali malaria, dengue e febbre enterica. Poi ci sono i virus ritenuti “emergenti”, come zika (prevalentemente in America Latina) ed ebola, nonché alcuni allarmi specifici, come la polio in Nigeria o la mers (sindrome respiratoria mediorientale) nell'area tra il Libano e l'Iran, con particolari criticità nei luoghi e nei tempi dell’afflusso massiccio legato ai pellegrinaggi (come quello a La Mecca).
La guida americana, oggetto di frequenti aggiornamenti nella versione digitale, include anche “buone notizie”, come il nuovo vaccino contro il colera, nonché consigli utili, che vanno dalle immunizzazioni alla prevenzione di alcuni disturbi diffusi, dalla nausea alla diarrea, dal problema del jet lag alla gestione delle alte quote, oltre naturalmente ai consigli alimentari.
In mezzo a consulenze e allarmi, non manca qualche curiosità, tra cui la stessa inclusione del nostro Paese tra quelli “a rischio”. La citazione è in particolare sul morbillo, che da noi ha rialzato la testa negli ultimi anni, complice qualche difetto nelle vaccinazioni. Il Ministero italiano della Salute si è quindi attrezzato in proposito anche con lo strumento di un bollettino settimanale.
E anche l'ultimo è tutt'altro che incoraggiante. 3346 casi e due decessi solo dall'inizio dell'anno, in larga parte (88%) tra i non vaccinati o tra i vaccinati con una sola dose (7%). Non mancano per i pazienti alcune complicanze (35%), tanto che nel 40% si arriva al ricovero. E non ne sono immuni neppure gli operatori sanitari, con oltre 250 casi nel 2017. Solo la Romania ci supera in tali cifre a livello europeo. Magra consolazione: l'allerta morbillo è lanciata, oltre che per Italia e la stessa Romania, anche per Germania e Belgio. “Andateci solo se immunizzati”, dicono gli americani. E questo dovrebbe preoccupare, a maggior ragione, anche chi ci vive.

Lo chiamano oramai così, il “diabete urbano”. Non è una variante della patologia ma una drammatica presa d'atto di quanto essa coinvolga primariamente le città, tanto da suscitare in questi giorni analisi, convegni (uno al Senato, organizzato dal “think tank” Health City Institute), e perfino un appello che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha rivolto a se stessa, ossia ai sindaci, per sensibilizzarli al problema.
L'impatto della malattia in Italia ha raggiunto cifre impressionanti: nei conteggi ufficiali sono 3,3 milioni le persone colpite, secondo l'Istat, ossia il 5,4% della popolazione, e molte di loro sono esposte ad altri rischi sanitari. Si stima ad esempio, che ogni 7 minuti un diabetico abbia un attacco cardiaco, ogni 10 un altro sviluppi un problema serio alla vista, mentre solo la metà dei pazienti consegue un buon controllo glicemico.
Tra i tantissimi pazienti, ci sono molti che si curano male, non seguono per bene le terapie o le indicazioni alimentari, e ci sono anche quelli (come l'amato Paolo Villaggio) che scelgono perfino di non curarsi affatto. E poi c'è un nodo ulteriore, rappresentato dal fatto che tali cifre sono solo una sottostima dell’entità del problema, tant'è che si calcola che c’è un altro milione di italiani affetti da diabete senza saperlo.
Se poi si scompone tale dato su base territoriale, balza appunto agli occhi il problema delle città. Oltre la metà dei diabetici italiani vive nei cento più grandi centri urbani. A Roma, ad esempio, l'incidenza della patologia sale, dalla citata media nazionale del 5,4%, al 6,5%. E se si mette la lente sul rapporto tra centro e periferie, si vede che in queste ultime la proporzione si impenna al 7,3%. “Una chiara evidenza dell'impatto dell'ambiente sullo sviluppo della malattia”, nota Chiara Frontoni, presidente del Comitato scientifico dell’Italian Barometer Diabetes & Obesity Forum.
Al di là degli aspetti terapeutici, e dei progressi scientifici in materia, il tema chiama dunque in causa l'assistenza in senso lato. Il diabete è una “pandemia sociale”, nella definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e come tale va “curato”. Coinvolge selettivamente le aree urbane, specie quelle più disagiate, nonché le fasce deboli, a iniziare dagli anziani. E lo fa in almeno due aspetti, incidendo sia sul rischio di ammalarsi (stili di vita, qualità dell'aria, alimentazione), sia sulla difficoltà a curarsi, data la solitudine in cui si trovano in città moltissimi pazienti, soprattutto in età avanzata. “Le campagne di comunicazione per migliorare i comportamenti privati di prevenzione sono fallimentari”, ha ammesso anche il presidente della Società Italiana di Medicina Generale, Claudio Cricelli. Si tratta invece di non lasciare le persone sole. E questo è un tema non solo sanitario.

Sorpresa: tagliare drasticamente il consumo di sale potrebbe non essere benefico. E’ uno dei segnali più sorprendenti lanciati dal 27mo Congresso della Società Europea dell’Ipertensione, tenutosi nei giorni scorsi a Milano.
E sembra contrastare con l’ampia letteratura in materia, specie in relazione al tema stesso della pressione arteriosa, nonché con le politiche attivate anche in Italia per limitarne l’assunzione nell’obiettivo di benefici sanitari, e perfino economici, già segnalati su questo portale. In realtà, a ben vedere, la contraddizione non c’è, il segnale si limita a un monito, comunque rilevante, a evitare gli “integralismi”. Nel dettaglio, gli studi clinici hanno finora accertato che l’abbassamento di pressione avviene con un consumo di sale inferiore ai 3 grammi al giorno, e tuttavia “la dose ottimale di sodio per il benessere dell’organismo è un dato ancora da stabilire”, ha rimarcato il presidente del Congresso Giuseppe Mancia, nonché autore di una ricerca di revisione in materia.
La conclusione di tale studio rimane quella di evitare gli eccessi salini, ma senza scendere sotto la soglia dei 7,5 grammi, “perché non conosciamo ancora le conseguenze per la salute” di tagli ulteriori. Il nostro corpo, dinanzi soprattutto a situazioni patologiche, ha bisogno di equilibri, e anche una limitata presenza di sodio può essere un fattore attivo, sicché le soluzioni drastiche sembrano da evitarsi, in quanto prive di riscontri scientifici certi.
Il tema è serio, specie in quanto l’ipertensione arteriosa coinvolge un adulto europeo su tre, superando addirittura il fumo e l’inquinamento atmosferico come fattore di rischio cardiovascolare, con prospettive di peggioramento legate all’invecchiamento della popolazione. Un problema esteso, dunque, e al contempo spesso affrontato male. La metà dei pazienti, ad esempio, sospende arbitrariamente le cure, e si controlla in modo discontinuo.
La scarsa aderenza terapeutica è spesso determinata dal fatto che si sta provvisoriamente un po’ meglio. E le soluzioni drastiche fai-da-te come l’azzeramento del sale in generale non hanno un riscontro scientifico. Sono tutte cattive abitudini da eliminare, perché l’ipertensione richiede invece un’attenzione cauta quanto di lungo periodo. Gli eccessi e le scorciatoie, incluso l’azzeramento del sale, non sono una soluzione.

Viene definita “una delle scoperte più importanti nella storia della ricerca oncologica”. Arriva da Napoli, dagli scienziati del Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina), in collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia, meritando la pubblicazione anche nella prestigiosa rivista internazionale Science. La novità è nell’individuazione di una sorta di “interruttore” biologico, responsabile della proliferazione incontrollata delle cellule tumorali, “spento” il quale la crescita cancerogena stessa verrebbe bloccata.
Al cuore della scoperta, giunta al culmine di un percorso decennale, c’è lo studio dei cosiddetti “lisosomi”, micro-organi cellulari che funzionano come dei veri e propri “termovalorizzatori”, sprigionando energie (da molecole “dormienti”) quando mancano, ad esempio in assenza di cibo o nel contesto di un esercizio fisico prolungato. L’aspetto cruciale è che tale meccanismo invece si arresta automaticamente col ripristino dell’alimentazione e del riposo. Ebbene, è emerso che il “blocco” dei lisosomi fa inceppare tale dinamica, e induce alla replicazione e alla crescita delle cellule cancerogene, in particolare di melanomi e tumori al rene e al pancreas. Specularmente, il loro “sblocco” ferma l’avanzata tumorale, ripristinando tale meccanismo difensivo del corpo.
Sono diversi gli aspetti suggestivi di tale studio, oltre che promettenti. In generale, è interessante la sua metodica, che fa leva sugli aspetti endogeni delle capacità difensive del corpo, sicché l’orizzonte farmacologico diventa quello del loro ripristino. Più specificamente, l’analisi dell’attività dei lisosomi (e delle situazioni di loro malfunzionamento) è scaturita dallo studio di malattie cosiddette “rare”, già rivelatosi prezioso per la comprensione di altre patologie diffuse.
“Basti ricordare come le statine, farmaci comunemente usati per abbassare i livelli di colesterolo, siano stati sviluppati a partire dallo studio di una condizione rara, l'ipercolesterolemia familiare”, nota Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon (co-finanziatrice del progetto, insieme all’Airc). Ora si tratta di arrivare al dunque, specificando i rapporti di causa ed effetto, nonché i relativi antidoti. Sicché si va avanti, anche con annunciati contributi regionali.

“Una crisi di salute pubblica crescente e inquietante”, la definiscono gli studiosi dell'Università di Washington che, con una pubblicazione sul New England Journal of Medicine, hanno tentato un'analisi su scala globale dell'ampiezza del fenomeno e delle sue conseguenze nefaste, esaminando i dati raccolti dal 1980 in ben 195 Paesi.
La stima complessiva è di oltre due miliardi di persone che soffrono di problemi di salute legati al sovrappeso, incluse malattie cardiovascolari, disturbi metabolici e una dozzina di tipi di tumori. Problemi che possono essere addirittura fatali, con circa quattro milioni di morti nel 2015 attribuiti proprio ai chili di troppo. I rischi maggiori sono legati all'obesità, definita oltre il valore 30 dell'indice di massa corporea (coinvolgendo circa 600 milioni di adulti e oltre 100 milioni di bambini), ma il problema riguarda anche le persone “solo” in sovrappeso, tanto che quasi il 40% di tali decessi riguardano queste ultime.
Nel confronto tra Paesi gli Stati Uniti si confermano al vertice dell'amara classifica, ma dati preoccupanti stanno emergendo anche dai paesi emergenti, nonché perfino in quelli meno sviluppati. A guidare la classifica (in termini percentuali) degli adulti obesi è l'Egitto, mentre Cina e India conducono quella dei bambini. E neppure l'Africa sub-sahariana ne è immune, con alte proporzioni in sovrappeso soprattutto in Burkina Faso, Mali e Guinea Bissau, e una media continentale di obesi salita intorno al 7%.
Insomma, all'opposto degli obiettivi fissati dalle agenzie alimentari e sanitarie dell'Onu, l'obesità è addirittura raddoppiata negli ultimi venticinque anni. E anche l'Italia della celebrata dieta mediterranea non se la cava bene. Secondo le ultime analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, i connazionali in sovrappeso sono oltre un terzo della popolazione adulta, e uno su dieci è obeso. Un aspetto rilevante è la discrepanza regionale, con i dati peggiori nelle regioni meridionali, le stesse che sono alle prese con le più serie difficoltà economiche. Vale allora lo stesso di quanto osservato su scala globale. Il problema non è più solo la malnutrizione, ma la qualità alimentare. In altre parole, spesso i chili di troppo non sono più, come un tempo, segno di “benessere”, bensì al contrario del fatto che si è costretti a mangiare male, con tutto quel che consegue per la salute.

Il momento del sorpasso è arrivato. L'anno scorso i farmaci equivalenti in Europa hanno scavalcato, e di parecchio, quelli di marca, arrivando al 62% di quelli globalmente dispensati nel Vecchio Continente. Lo storico traguardo è annunciato nell'annuale “Global Healthcare Trends and Outlook”, presentato nei giorni scorsi a Lisbona, dove si riunivano le associazioni europee e mondiali dei produttori (Medicines for Europe e IGBA).
Per capire cosa significhi per la salute pubblica, tale dato va incrociato con quello sull'onere degli stessi generici per i bilanci sanitari dei Paesi europei, ossia solo il 4%. Quel 62% è infatti conteggiato in volumi, mentre in valori si scende al 29%, proprio per il loro costo inferiore. Negli Stati Uniti l'avanzata è ancor più netta (70% in quantità, 23% in valore), ma dati promettenti e prospettive di ulteriore crescita si segnalano anche negli altri Continenti, inclusi i paesi poveri, con quel che ne deriva per il potenziale ampliamento della platea di pazienti curabili.
“Equivalenti e biosimilari devono rimanere al centro di tutte le politiche di efficientamento dei sistemi sanitari universalistici”, commenta il coordinatore dello studio Alan Sheppard, invocando politiche di prezzo efficaci e concertate, nonché “adeguati strumenti di comunicazione e cultura capaci di far crescere la consapevolezza sul valore del comparto”.
Ed è quel che ora si prova a fare in Italia, anche dal basso, con il secondo anno di campagna informativa “IoEquivalgo” avviata in questi giorni dalla rete associativa di Cittadinanzattiva, che attraverserà una decina di città di altrettante Regioni. Con l'amara motivazione del ritardo del nostro paese nel settore, seppure in parziale recupero. Nel primo trimestre del 2017, il ricorso agli equivalenti nei medicinali di fascia A (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) è aumentato su base annua del 2,8% portandone la quota di mercato al 20,88% in volumi, e all'11,6% in valori.
Ancora troppo poco, ed è una carenza che configura uno spreco, per le risorse pubbliche e private. E a proposito di sprechi, nei giorni scorsi, a Roma, è stato presentato anche il rapporto annuale dell'European Healthcare Fraud & Corruption Network (Ehfcn). Tra frodi, corruzione, sprechi e abusi si stima che l'Italia mandi in fumo ben 6 miliardi di euro l'anno. Ci sono nodi amministrativi e colpe specifiche, ma la priorità, a detta dell'Ehfcn, è quella, di nuovo, di un salto in avanti nella generale “cultura” anti-frode. Che si concreta anche nella scelta dei medicinali.

Anche gli operatori sanitari più scettici riconoscono nell’informazione – e nella rivoluzione tecnologica che l’ha moltiplicata negli ultimi decenni – una chiave di volta essenziale, dalla “cartella clinica” del paziente all’insieme delle notizie scientifiche che permettono un aggiornamento continuo, a beneficio dei pazienti oltre che degli stessi specialisti. Al contempo, però, permane una “controindicazione” quando arriva la “notizia”: difficilmente essa è di immediato impatto per la salute, trattandosi di scoperte che necessitano poi di anni di sperimentazioni prima di poter arrivare all’applicazione clinica.
In questo sta la “rivoluzione” annunciata, proprio nel nostro Paese: quello di una mappatura genomica dei tumori, una sorta di “oncochip” capace di captare con precisione e immediatezza le alterazioni tumorali e poter quindi calibrare meglio la cura farmacologica sul singolo paziente. Il progetto, finanziato dal Ministero della Salute, sarà realizzato dalla rete d ricerca oncologica italiana chiamata “Alleanza Contro il Cancro” (Acc).
“Prima della medicina personalizzata c’è la ricerca personalizzata”, ha detto in conferenza stampa nei giorni scorsi lo stesso ministro Beatrice Lorenzin. “Avremo la possibilità di mettere a sistema i tumori di ogni singolo paziente, eseguire terapie mirate e garantire ai medici di utilizzare al meglio i farmaci innovativi”, ha aggiunto, rivendicando che siamo “il primo Paese ad aver avviato un progetto come questo in maniera totalmente gratuita”. Altrove il progetto è già in atto, specie negli Stati Uniti, ma a costi privati rilevanti.
Il presupposto, ha spiegato il Direttore Scientifico dell’Acc Giuseppe Pelicci, è la peculiarità di ogni tumore, nonché la sua declinazione in una decina di mutazioni genomiche. Lo “sforzo computazionale straordinario – spiega – consiste nel collegare il genoma del paziente a tutte le informazioni genomiche disponibili nel mondo, in maniera tale da riassumere per ogni paziente tutta la conoscenza scientifica disponibile per effettuare la scelta migliore”. In altre parole, “ogni paziente diventerà un progetto di ricerca in sé”, con tutto quel che consegue per una definizione più appropriata della sua terapia, nonché di quella del paziente successivo, innescando un circolo virtuoso di progressiva personalizzazione delle conoscenze e qualità delle cure.
Il calendario prevede uno studio di fattibilità a partire da ottobre, specie in Sicilia, nel quale sarà rilevata la sequenza del genoma di un migliaio di tumori al polmone. Dall’anno prossimo il progetto sarà diffuso in altre regioni e per altre forme tumorali per le quali è prevista la rimborsabilità del Servizio Sanitario Nazionale. “Il potenziale è enorme”, assicura l’Acc.

Al millenario quesito filosofico - “ma l'uomo è alla base buono o cattivo?” - se si dovesse cercare risposta nelle donazioni di sangue, vi sarebbero pochi dubbi. Ci sono oramai oltre 112 milioni di donatori, ed è un dato in continuo aumento che al contempo necessita di un'ulteriore spinta. Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale dei Donatori – Paese capitale di turno il Vietnam – con qualche indicazione interessante anche sul nostro Paese.
Il dato incoraggiante è appunto quello di un buon incremento globale delle donazioni volontarie, conteggiato in 10,7 milioni in più nel 2013 rispetto a soli cinque anni prima. Le quote maggiori si registrano tradizionalmente nei Paesi abbienti, ma c'è un sensibile recupero anche in quelli meno sviluppati. La differenza è soprattutto nei beneficiari della donazione: nei primi si tratta in larga maggioranza di anziani, tra gli altri sono soprattutto bambini sotto i 5 anni di età.
Complessivamente sono 74 gli Stati che raccolgono (su base volontaria) oltre il 90% delle esigenze della propria popolazione, 57 quelli che arrivano alla sostanziale auto-sufficienza, e tra questi c'è l'Italia. Non mancano però le criticità. Anzitutto le catastrofi, tra guerre e calamità naturali, che hanno coinvolto oltre 250 milioni di persone solo nell'ultimo anno, e hanno causato più di un milione di decessi negli ultimi 10, sicché le donazioni sono ancora ben lontane dall'“obiettivo 100%” lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In secondo luogo, la donazione è preziosa anche quando coinvolge la raccolta selettiva di emoderivati, che rimane assai più lontana dalla sufficienza, considerando che viene effettuata in poco più di un terzo dei Paesi.
L'Italia rientra nella categoria dei più virtuosi, grazie tra l'altro all'impegno dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e di tantissime persone. Ma la guardia non va abbassata, anche perché emerge qualche piccolo allarme dalle ultime cifre. Nel 2016 i donatori nel nostro Paese sono stati 1 milione e 688mila, circa 40mila in meno rispetto all'anno precedente, nonché il dato più basso dal 2011. E' in parte un calo fisiologico, dovuto all'invecchiamento della popolazione, ma questo rappresenta una ragione in più per incentivare i giovani. Lo slogan “Dona ora, dona spesso” è rivolto anzitutto a loro.
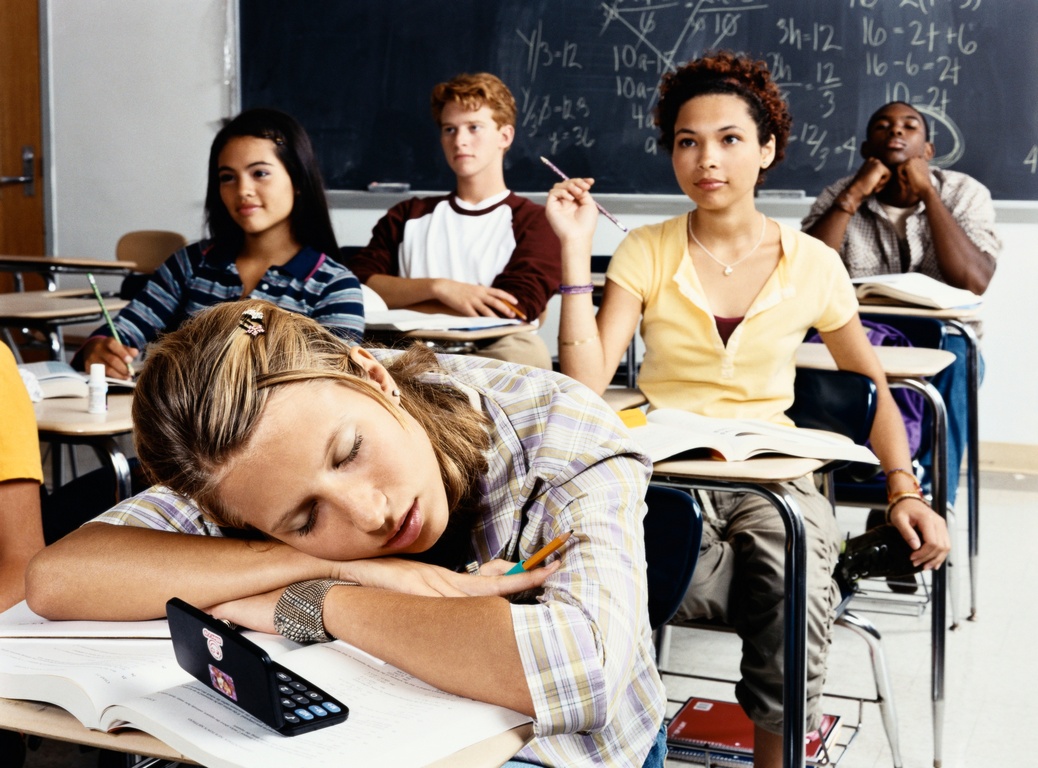
Al rito di passaggio degli esami di Maturità se ne accompagnano altri, in particolare quelli dei consigli impartiti agli studenti alla vigilia, per definizione non sempre graditi. C’è comunque qualche novità scientifica in proposito, che va presa sul serio, e pone l’accento sulla qualità e, in particolare, sulla regolarità del riposo. A beneficio degli studenti, naturalmente, ma in realtà rivolta a tutti.
Si tratta di una ricerca realizzata a Boston e pubblicata su Scientific Reports, monitorando 61 studenti (dell’Università di Oxford, nella fattispecie) nelle loro abitudini notturne, e cercando legami con la successiva “performance” all’esame. Il primo esito, tutt’altro che sorprendente, è che il nesso c’è, sicché un cattivo riposo è strettamente correlato a esiti peggiori all’atto della prova.
Ma c’è una variabile a svettare in cima agli indicatori della qualità del sonno, ed è la costanza negli orari. “E’ emerso che andare a dormire e svegliarsi più o meno alla stessa ora ha la stessa importanza della durata del sonno”, notano gli scienziati americani, osservando inoltre come l’obiettivo della regolarità sia più facilmente perseguibile dell’altro - la durata - su cui incidono invariabilmente fattori individuali e l’incombenza dello stesso stress.
L’irregolarità è “scombussolante”, come facilmente percepibile, ma il punto è che ha precise conseguenze fisiologiche, come il cosiddetto “ormone del sonno”, la melatonina, il cui rilascio è risultato ritardato di ben tre ore tra gli studenti meno costanti. Tecnicamente, questo significa che, se essi hanno l’esame alle 9, per il loro corpo è come fossero ancora le 6 del mattino, con tutto ciò che consegue sul livello di “veglia” psico-fisica. E c’è un effetto ulteriore. E’ emersa una causalità tra la regolarità del sonno e la “qualità oraria” dello stesso: ossia, i meno costanti sono anche quelli che necessitano di più riposo nelle ore diurne, altra abitudine ritenuta poco sana (sempreché non si tratti di riposini di pochi minuti).
Sui consigli alimentari, poi, i media si scatenano. Ne ricordiamo qui solo un paio, legati proprio al sonno. Mangiare bene ma senza abbuffate né alcolici prima di coricarsi. E, al risveglio, vietato saltare la colazione, anche se lo stomaco sembra chiuso dall’ansia dell’imminente prova.

Sulla qualità della nostra alimentazione conta anche l’orario, con tutto quel che consegue per il peso-forma e molto altro. Una ricerca sperimentale dell’Università della Pennsylvania, presentata nei giorni scorsi al Congresso Mondiale “Sleep 2017” a Boston, ha dimostrato più che mai il nesso tra la tempistica dei pasti e una catena di effetti per la salute.
Il “background” della ricerca era nel pregresso di conoscenze proprio sui disturbi del sonno - più che sul cibo di per sé – ossia sul loro impatto sui problemi di peso e sul processo metabolico nel suo insieme. E si è incrociato sistematicamente tale “acquis” con il tema di “quando si mangia”. Il gruppo di volontari è stato quindi sottoposto per otto settimane a un regime alimentare (tre pasti completi e un paio di spuntini) che si esauriva tra le 8 del mattino alle 19 di sera, e per altre otto (col “cuscinetto” di un intervallo di due settimane) la medesima dieta è stata traslata in avanti di quattro ore.
L’effetto è stato evidente. Mangiando più tardi il peso aumentava, e per giunta si innescavano altri profili metabolici negativi per la salute, con tra l’altro l’aumento della produzione di insulina, di glucosio a digiuno, di colesterolo e di trigliceridi, e quindi di rischi di diabete, problemi cardiovascolari e perfino respiratori.
Su tutto questo sorge il sospetto di una possibile controindicazione. Quella secondo cui il mangiare “troppo presto” possa incentivare l’abitudine, deleteria per la salute, di mangiare in uno stato pseudo-sonnambolico, in tarda notte. E invece no, al contrario il consumo diurno sembra agevolare conseguenze anche ormonali che “saziano” meglio il corpo, inibendo le irregolarità alimentari.
“Cambiare le abitudini alimentari non è mai facile, ma mangiare prima può valere davvero la pena per prevenire effetti sanitari cronici”, dicono gli studiosi. Il messaggio universale è dunque che anticipare un pochino i pasti, rispetto alle proprie consuetudini, non può far altro che bene.

La diagnosi precoce è sempre cruciale, e lo è in particolare per una patologia come il Parkinson, in cui il ritardo è un problema assai diffuso. Quando viene effettuata, larga parte dei neuroni dopaminergici – fondamentali per il movimento – risulta spesso già compromessa, mettendo a serio rischio l’efficacia dei trattamenti esistenti, potenzialmente capaci di prevenire o almeno ritardare la malattia. In tutto questo sta l’importanza delle novità sulla diagnostica.
L’ultima è annunciata (tramite una pubblicazione sulla rivista Brain, nonché presso il recente Congresso mondiale sul Parkinson, tenutosi a Vancouver) da un neurologo italiano, Lazzaro Di Biase, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in collaborazione con l’Università di Oxford. Si tratta di un semplice orologio da polso, già brevettato, che consentirebbe di rilevare in una decina di secondi non solo il tremolio delle mani (che può derivare da una pluralità di motivi), ma anche l’eventuale presenza specifica del morbo.
“Da anni i neurologi tentavano di arrivare a questo strumento, un indice diagnostico non invasivo, con un'accuratezza vicina al 92%”, rivendica Di Biase, ricordando le tecniche onerose (foriere anche di lunghe liste d’attesa) finora in uso, come lo “Spect cerebrale”. Qui si tratterebbe invece di un semplice dispositivo che “necessita solo di un accelerometro che costa dai 3 ai 15 euro”.
Una buona notizia, insomma, per i circa i 300mila malati di Parkinson, e soprattutto per quelli futuri. Il tema dell’orologio ha suscitato del resto altre novità tecnico-scientifiche. Nei mesi scorsi un documentario della BBC (della serie chiamata “The Big Life Fix”) ha svelato i buoni esiti dell’esperimento di un altro orologio su misura, che aiuterebbe i malati a recuperare la capacità di scrivere e disegnare, limitando i tremori e incrementando le capacità manuali di controllo.
Applicazioni diagnostiche e fisiologiche innovative, ma anche tecniche psicologiche di recupero cognitivo. L’orologio è protagonista, da tempo, di sperimentazioni efficaci nell’ambito di varie patologie neurodegenerative, incluso l’Alzheimer: sin dagli anni ’80, in Svizzera, una ricercatrice di origine italiana, Angela Furlan, sperimentò una metodica psicoterapeutica incentrata proprio sul ruolo fondamentale delle capacità di controllo temporale.

“E’ una sanità pubblica in prognosi riservata”, lamenta la Fondazione Gimbe nel suo ultimo rapporto, discusso nei giorni scorsi in Senato, sulla “Sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale” riferita primariamente ai prossimi anni. Il dato critico di base è oramai piuttosto chiaro, quello di una “domanda di salute” che cresce in relazione all’invecchiamento della popolazione e al contempo di “un’offerta” messa a rischio dalle esigenze di bilancio pubblico. In mezzo ai grandi numeri, sale la sofferenza dei singoli, con la piaga, confermata proprio in questi giorni da un altro rapporto realizzato dal Censis, sugli italiani costretti a rinunciare alle cure.
Nel mirino del Gimbe anzitutto i tanti sprechi, tra corruzione, inefficienze e visite inutili (al prezzo di non garantire talvolta quelle necessarie), conteggiati nel 2016 a oltre 22 miliardi di euro, seppure in lieve calo rispetto all’anno precedente. E poi c’è una denuncia politica esplicita: “Secondo il Def 2017 nel triennio 2018-20 il rapporto tra spesa sanitaria e Pil diminuirà dal 6,7% del 2017 al 6,5% nel 2018. E arriverà al 6,4% nel 2019: per la prima volta sotto la soglia d'allarme fissata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, pari al 6,5%, al di sotto della quale si riducono le aspettativa di vita”, spiega il presidente del Gimbe Nino Cartabellotta, che specifica: “Se inizialmente il definanziamento della sanità era conseguenza della crisi, oggi invece è diventata una costante irreversibile”.
Una scelta deliberata, dunque, e per giunta evitabile. La stessa Fondazione, con un “position statement”, ha ribadito nei mesi scorsi l’enorme potenziale offerto da un più esteso ricorso ai farmaci equivalenti che, seppur in recupero, vedono l’Italia ancora in ritardo rispetto agli altri paesi avanzati. Ed è su quel ritardo che è iniziato il secondo anno di campagna “IoEquivalgo” della rete associativa di Cittadinanzattiva, per informare i cittadini proprio sulla documentata e completa equivalenza dei generici, a un prezzo inferiore.
A pagare tali ritardi sono i cittadini, fino al punto di dover abbandonare le terapie. Il Censis rilancia l’allarme, ed è un allarme in preoccupante crescita. Nell’ultimo anno, si legge nel suo rapporto, gli italiani che hanno rinunciato o rinviato le prestazioni sanitarie sono stati addirittura 12,2 milioni, oltre un milione in più rispetto al 2015. Di questi, due terzi sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti.
Per giunta, i pazienti hanno speso di tasca propria per le cure non di meno, ma di più, addirittura 35,2 miliardi solo l’anno scorso. Insomma, si taglia pian piano sul Servizio Pubblico, scaricando i costi sulle tasche dei cittadini, molti della quali non ce la fanno più. Non pare un modello accettabile, senza la salute un Paese non può star bene.

E’ un problema diffuso quanto sottovalutato. Le disfunzioni della tiroide sono state oggetto a fine maggio, non senza qualche colpa di sottovalutazione dei grandi media, di un’apposita “Settimana” e, all’interno di essa, di una “Giornata”, promossa dalle associazioni internazionali ed europee, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questa tematica.
Pur agendo da co-protagonista nell’equilibrio metabolico dell’organismo umano la tiroide resta una ghiandola poco conosciuta e i sintomi del suo malfunzionamento si prestano facilmente, almeno nelle fasi iniziali, ad essere confusi con altre problematiche. Un eccesso (l'ipertiroidismo), infatti, provoca un'accelerazione dei processi, causando dimagrimento, irritabilità, rischi cardiovascolari, mentre un difetto (l'ipotiroidismo), li rallenta, innescando anche stanchezza, a volte difficoltà di concentrazione, in qualche caso anche depressione. Nelle difficoltà di diagnosi capita dunque di non accorgersi subito della natura del problema che, in realtà, è assai diffuso, coinvolgendo – si stima – circa sei milioni di italiani.
Qualche problema c'è nell'ambito terapeutico, con la recente presa d'atto di un eccesso di interventi chirurgici in Italia, a fronte di buoni rimedi farmacologici. “Il carcinoma tiroideo ha un comportamento clinico peculiare: difficilmente infiltra i tessuti circostanti, crea metastasi e porta a morte il paziente. Molte di queste varianti “buone” per anni sono state trattate come tutti gli altri tumori e asportate chirurgicamente”, spiega Luciano Pezzullo, presidente dell'Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia Italiane.
Non mancano peraltro le buone notizie, anche sul fronte della prevenzione, inclusi gli esiti del programma nazionale di “iodioprofilassi” introdotto dodici anni fa. La carenza di iodio è riconosciuta come un rilevante fattore di rischio, specie in gravidanza. Il fabbisogno quotidiano di iodio in un adulto sano è di 150 microgrammi, e sale quasi al doppio fino all’allattamento. Ebbene, in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sia sulle vendite che sulla situazione clinica degli italiani, emerge che in solo una dozzina d’anni il consumo di sale iodato ha superato il 60% di quello complessivo di sali, raddoppiandosi.

Li hanno presi, frullati, liofilizzati e chissà che altro. Poi li hanno lanciati nello spazio. E loro - tomi tomi, avrebbe commentato Totò - hanno mantenuto integralmente la loro funzionalità biologia nell’arco di nove mesi, con tassi di fecondazione e nascita analoghi a quelli “terrestri”, tant’è che al ritorno sul pianeta hanno procreato prole sana e a sua volta fertile, generando poi “nipoti” altrettanto sani. Il tutto in un ambiente spaziale bombardato da radiazioni circa un centinaio di volte superiori rispetto a quelle registrate sulla superficie terrestre.
Protagonisti della singolare avventura gli spermatozoi di topolini al centro di una costosa ricerca giapponese che ha coinvolto la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) nel tentativo di mettere un punto fermo sulle prospettive anche sanitarie di un’eventuale vita extraterrestre. Il tema è serio e affascinante, anche per la ricerca medica, tanto da meritare la pubblicazione nella rivista scientifica internazionale Pnas, sebbene a detta degli stessi scienziati dell'Università di Yamanashi permangano “quesiti e dubbi da sciogliere”.
Lo studio sembrerebbe comunque dimostrare che la riproduzione extraterrestre è possibile tra i mammiferi e che esiste anche un potenziale per la costruzione di una “banca del seme”, analoga a quella allestita per le piante in un’isola norvegese.
Certo i dubbi ci sono, ma forse c’è anche tutto il tempo per cercare di risolverli: “Se i campioni di sperma dovessero essere conservati nello spazio per periodi più lunghi è probabile che i danni genetici aumenterebbero e supererebbero le capacità riparative degli ovuli”, ipotizzano ad esempio gli studiosi nipponici. Gli stessi hanno però già ipotizzato qualche soluzione, suggerendo che uno scudo di ghiaccio potrebbe servire a proteggere i campioni dalle radiazioni.
E c’è anche chi nota che l’orbita dell’Iss non è abbastanza lontana da consentire la simulazione di una sperimentazione “lunare” o ancor più remota. “L’orbita dell’Iss si trova sotto la protezione della fascia di Van Allen, il campo magnetico che devia le radiazioni più alte evitando che colpiscano la Terra”, ha infatti commentato uno scienziato alla Bbc, osservando che il problema non sta solo nel concepimento, ma anche nella protezione della gestante nell’arco dei nove mesi.
Difficile per ora prevedere le ricadute immediate dello studio per la ricerca medica. Sembra plausibile però ritenere che siano state poste le basi per evitare l’estinzione delle varie specie quando il sole finirà il suo ciclo: un appuntamento che gli esperti collocano tra circa 5 miliardi di anni.

C’è un “mantra” che si ripete nel mondo della salute: più precoce è la cura migliori sono i risultati. Ed è vero: troppo spesso le diagnosi tardive rendono meno efficaci i trattamenti e le possibilità di guarigione. A volte, però, accade il contrario e si esagera per eccesso. Ne è convinta la Fondazione Gimbe - istituita per sostenere la formazione continua degli operatori sanitari, migliorare la qualità metodologica della ricerca e l’interazione con le decisioni professionali e di politica sanitaria - che proprio di recente ha lanciato un allarme in materia di chirurgia, contestando l’eccesso di esami prima di un intervento, facendo anche riferimento alle “linee guida” dell’autorità britannica in materia.
“L'utilizzo routinario di test preoperatori per la chirurgia elettiva non incide sulla gestione chirurgica e il riscontro di risultati falsamente positivi genera un ulteriore sovra-utilizzo di prestazioni, come terapie inappropriate, consulti specialistici ed esami invasivi che possono determinare danni ai pazienti”, denuncia Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. Non è un monito da poco, soprattutto se si tiene conto delle conseguenze dichiarate: sprechi economici e di tempo, “ritardi nel processo chirurgico” e, infine, danni per il paziente.
Il Gimbe fa riferimento per inciso anche alla norma contenuta all’articolo 5 della legge n. 24/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo), dove il dimostrato rispetto per le “linee guida elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché da società scientifiche, oltre che da buone pratiche clinico-assistenziali” varrebbero come ciambella di salvataggio contro eventuali accuse di imperizia. Il tema è quello - delicatissimo – della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il punto nodale è che in Italia le buone pratiche ci sono, le linee guida formalmente ancora no.
In mancanza di meglio Gimbe fa riferimento alle direttive del National Intitute for Health and Care Excellence, che parte da un suggerimento solido e pieno di buon senso: “Includere i risultati di tutti i test pre-operatori effettuati dal medico di famiglia quando si richiede un consulto chirurgico, oltre che considerare tutti i farmaci assunti dal paziente prima di effettuare qualsiasi test pre-operatorio, proprio per evitare inutili duplicazioni”. Si può fare. Si dovrebbe fare. Anche senza guideline.

“I bambini crescono”, titola il 73mo Congresso della Società di Pediatria (Sip), in corso tra il 29 maggio e il I giugno a Napoli, lanciando già un duplice, correlato messaggio: “La pediatria è uscita dal confine temporale dell’età evolutiva - spiega il Presidente della Società Alberto Villani - “ha responsabilità dello stato di salute per tutta la vita, perché ciò che avviene nei primi anni fa la differenza”. A questo si lega il tema più specifico, quello dell’adolescenza, che segna il passaggio dall’età pediatrica a quella adulta, configurando talora un “limbo” anche sotto il profilo dell’assistenza sanitaria.
E all’evidenza il bisogno c’è ed è altissimo. Si stima che oltre il 15% dei ragazzi tra i 15 ai 17 anni soffra di una malattia cronica, e il 3,2% ne hanno addirittura più d’una, a iniziare dalle patologie allergiche e quelle respiratorie. Sono cifre che echeggiano un allarme, ancor più forte ed esteso, lanciato proprio nei giorni scorsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), con la pubblicazione del Rapporto “Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation”. Un richiamo all’attenzione nell’ambito dei Piani Sanitari nazionali, e la denuncia di un dato di fondo largamente negletto, ossia il decesso nel mondo di tremila ragazzi al giorno, ossia 1,2 milioni l’anno.
Nello specifico, le principali cause sono anzitutto gli incidenti stradali, poi le malattie respiratorie, in alcune aree del pianeta perfino le complicazioni della gravidanza, i disturbi neurologici, nonché i suicidi e i decessi accidentali legati a comportamenti autolesionistici. Da notare che questi ultimi salgono addirittura al vertice delle cause di morte tra gli adolescenti in Europa.
Dall’Oms le raccomandazioni spaziano dall’educazione scolastica nelle scuole, limiti più stretti al consumo di alcol, e soprattutto un’assistenza sanitaria adeguata. Il passaggio dal pediatra al medico di famiglia, tra i 14 e i 16, è un momento delicato, che viene sostanzialmente lasciato alla discrezione e responsabilità dei singoli operatori e famiglie. Addirittura, “ci siamo accorti con stupore che esiste una larga fascia di ragazzi per i quali il Sistema Sanitario Nazionale non prevede visite mediche – ha denunciato nei mesi scorsi Piernicola Garofalo, presidente della Società Italiana per la Medicina dell’Adolescenza. Insomma si possono fare psicologie e sociologie, ma il dato di fondo è che quei ragazzi non ricevono l’attenzione che richiedono.

Un Paese ancora relativamente “sano”, un Servizio Nazionale che, pur tra mille difficoltà e limiti, assicura ancora settori di eccellente assistenza, virtualmente rivolti a tutti. Ma anche una popolazione dove in tanti, troppi, a causa delle difficoltà economiche che continuano a mordere, arrivano al punto di non curarsi. Sono anni che denunciamo questa tendenza, e l’Istat, nel suo Rapporto annuale sulla Salute divulgato in questi giorni, ne fornisce un’amara conferma, con riferimento anche al lettino del dentista.
Nel 2015 il 6,5% degli italiani ha rinunciato alle terapie a causa dei loro costi, nel 2008 erano solo il 4%. E se poi si mette la lente sulle sperequazioni regionali e sociali, emergono realtà ancor più drammatiche. La proporzione di rinunce sale a oltre il 10% nel Mezzogiorno, e supera il 14% tra le fasce di reddito più deboli. Dati che poi si riflettono sulle condizioni di salute della popolazione, che risultano migliori al Nord Italia, nonché tra i più ricchi.
Insomma, l’amara realtà è che il portafoglio è un passaporto anche in quest’ambito, e la salute orale non fa eccezione. Nel 2005 circa il 40% delle famiglie italiane si rivolgeva al dentista o all’ortodontista, proporzione scesa di almeno due punti nell’arco di dieci anni. Per gli addetti ai lavori, si tratterebbe del resto solo di una sottostima del calo avvenuto. E qui, più che mai, il nodo è nei costi. Come documenta anche un’indagine di un’agenzia privata (l’Osservatorio di “UniSalute”), ben il 36% dichiara di aver rinunciato alle cure perché non può permettersele, e il 17% denuncia aumenti di prezzo anche negli ultimi tempi.
Temi che chiamano in causa i decisori, e in effetti, anche in ambito regionale, si è aperta la discussione sull’ipotesi di assicurare le cure odontoiatriche ai meno abbienti, coprendone i costi. Alla buona prospettiva se ne aggiunge un’altra, ossia che sta emergendo qualche segnale di un’inversione di tendenza. I dati Istat si basano sul 2015, ma da un sondaggio dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, rivolto ai genitori di ragazzi under 14, emerge che il 90% li hanno portati dal dentista nell’ultimo anno almeno una volta.
Ci sarebbe dunque un recupero, ma i problemi non sono solo economici. La stessa indagine ad esempio rivela che oltre la metà della popolazione non sa che l’eccesso di zuccheri o una scarsa igiene orale siano tra le cause principali della carie, né che vanno curati anche i denti di latte, quando cariati. Alla nostra salute servirebbe dunque un po’ più di sicurezza materiale, ma anche di informazione.